Gli omicidi Laconi - Camarassa
di Francesco Loddo Canepa
Questo tragico episodio dominante la seconda metà del seicento sardo assurge ad indice delle tendenze e degli atteggiamenti della classe dirigente isolana. Rimandando all’opera magistrale dello Scano per tutti i particolari che sanno del romanzesco, ci restringeremo ai punti fondamentali.
La nomina del Marchese di Camarassa a Viceré di Sardegna (24.5.1665) in luogo del Governatore di Cagliari e Gallura Don Bernardino Mattia di Cervellon, giudicato dalla Corte uomo violento e pericoloso, la cui candidatura era stata appoggiata invece da gran parte della classe nobiliare sarda, aveva indispettito fortemente gli aderenti da cui era stato con ogni impegno sostenuto.
Costoro si strinsero nella lotta al loro maggior esponente Don Agostino di Castelvì, diviso da vecchia ruggine dal defunto don Blasco d’Alagon cui aveva inviato un cartello di sfida, avendo l’altro, per la passione non corrisposta verso una dama vagheggiata da entrambi, tentato di ucciderlo con un sicario prezzolato. Poco mancò che non avvenisse una baruffa a largo raggio tra i vassalli dei due feudatari (Don Francesco Melonda, prima partigiano del Castelvì e poi degli Alagon, tentò di corrompere un servitore del primo poiché gli fornisse il mezzo di assassinare il padrone. Il servo ne riferì al Castelvì che, attratto il Melonda – fidente nella complicità del servo stesso – in casa sua, lo ammazzò con diverse schioppettate).
Il figlio di Don Blasco, il giovane Don Artaldo Alagon, faceva parte della consorteria spagnola di casa Camarassa ove era considerato come il più cospicuo esponente del patriziato sardo. L’entourage viceregio assumeva di giorno in giorno verso la maggior parte della nobiltà isolana facente capo al Castelvì un contegno sempre più altezzoso e sprezzante che ne acuì ancor di più il dispetto ed il risentimento (L’entourage del viceré raccoglieva i funzionari spagnoli, poche famiglie patrizie, il principe di Piombino comandante le galere, Don Antonio Pedrassa Commissario della Cavalleria e i gentiluomini al servizio del Viceré. Con il Marchese di Laconi era la massima parte dei feudatari della nobiltà, dell’alta borghesia, del clero compresi gli alti prelati e i rappresentanti delle città costituenti lo stamento reale).
La questione degli impieghi preclusi ai sardi (Viceré, Reggente la Cancelleria, l’Arcivescovado di Cagliari e il Vescovado di Alghero, etc.) era ritornata sul tappeto più dibattuta che mai. A dire il vero, è da pensare che la questione non avesse la portata e la gravità che le si volle dare. Essa fu certamente alimentata da un atteggiamento di eccessiva intransigenza e da un punto d’onore in cui giocarono fortemente fattori personalissimi anche da parte dell’opposizione governativa visto che la Spagna era ormai convinta della fedeltà dei sardi.
Ma il partito dei Castelvì intendeva dare questa volta battaglia a fondo sostenendo il lealismo dei sardi verso la Corona e la loro idoneità ad occupare le più alte cariche.
Effettivamente, questa levata di scudi degli Stamenti non presenta alcuna incrinatura in senso antispagnolo e antidinastico. I nobili, i feudatari, l’alta borghesia erano intimamente devoti e legati alla Spagna da cui ottenevano benefici e privilegi.
Il viceré Camarassa dichiarava però inaccettabile e lesiva del prestigio della corona le domande degli Stamenti: gli Stamenti dovevano, come di consueto, votare nella solita forma il donativo al re e la benevolenza sovrana avrebbe preso in giusta considerazione le aspirazioni dei sardi (mentre il partito dei Castelvì intendeva rifiutare il donativo qualora non fosse stata concessa la contropartita degli impieghi).
Trascorse tutto il 1666 e le discussioni continuavano in forme assai aspre. Allora il viceré si appigliò al partito di inviare l’Avv. Fiscale don Antonio de Molina per rimettere alla Reggente e al Supremo Consiglio gli atti parlamentari e riferire sui fatti.
A loro volta gli stamenti come contromossa inviarono alla reggente quale sindaco il Marchese di Laconi don Agostino Castelvì, prima voce dello Stamento Militare, con l’incarico di ottenere l’accoglimento delle domande. Prima di partire il Castelvì fece il suo testamento.
La missione del Castelvì non fu fortunata. L’azione favorevole di suo cugino Don Giorgio di Castelvì Reggente del Supremo Consiglio di Aragona in Madrid fu neutralizzata dal potentissimo vice cancelliere di Aragona don Cristoforo Crespi di Valdaura che si mostrò pieno di rancore e di disprezzo verso i sardi e specialmente verso il Marchese di Laconi (a questo atteggiamento contribuirono tra l’altro rancori personali).
Le richieste presentate dal Castelvì erano molteplici: abolizione di qualsiasi monopolio ostacolante il libero commercio; abolizione di una nuova moneta di molinillo ed il ritiro della cattiva; altre erano di natura giurisdizionale ristrettive della facoltà del viceré come l’immunità parlamentare per i membri dello Stamento e per i consiglieri della città. Vi erano poi anche altre richieste, ma i punti su cui si insisteva maggiormente erano: la concessione di tutti gli impieghi ed uffici ai naturali dell’isola; la conferma di tutti i privilegi anche andati in disuso; la sospensione di qualsiasi provvedimento del viceré qualora l’arcivescovo di Cagliari come il titolato più qualificato e il consigliere in Capo alla città gli rappresentassero la convenienza di portare al sovrano la definitiva soluzione.
La corte invece non intendeva concedere oltre la metà degli uffici civili, i due governatorati di Cagliari e Sassari alternando nei vescovadi i titolari sardi con quelli di altre regioni. Forse con un atteggiamento conciliante del Cancelliere si sarebbe trovata una via d’accordo ma, mancata quest’azione riconciliatrice, le due parti si irrigidirono nelle rispettive pretese.
Il viceré intanto, sulle istruzioni della regina, abilitava (urtando maledettamente la nobiltà ed i feudatari) don Artaldo di Alagon a presiedere lo Stamento Militare nonostante la sua giovane età; poscia invitava il parlamento ad approvare incondizionatamente il donativo. I bracci ne domandarono invece la sospensione fino al ritorno di Don Agostino.
Il Castelvì, rientrato nel regno tra le ovazioni generali, riprese il suo posto di battaglia ancor più inasprito per l’arbitraria sua sostituzione col d’Alagon. La sera del 20-6-1668 il Marchese di Laconi cadeva crivellato di archibugiate e colpito da pugnale. Fu imbastito un primo processo, per ordine della R.Udienza, dal giudice Cano Biancarello mentre si ordiva dai nobili, convinti che il mandante dell’omicidio fosse il viceré, una congiura per vendicare la morte del Castelvì. Il padre Aleo fece allora avvertire il Camarassa del pericolo che correva e questi dichiarò al messo che Dio solo, conoscendo la sua innocenza, l’avrebbe salvato.
Ora sorge un grave dubbio. E’ possibile che alla nobiltà di Cagliari non fosse trapelato nulla della tresca (precedente l’omicidio) fra la Zatrillas, giovane moglie dell’attempato marchese, e don Silvestro Aymerich da lei sposato tre mesi dopo l’uccisione del marito? Che essa non avesse avuto neppure un’ombra di sospetto che l’assassinio del Castelvì potesse essere dovuto (come vuole la sentenza stessa) alla complicità dei due amanti? La relazione illecita, stando alle deposizioni, sarebbe stata anche sulle bocche della servitù.
I congiurati invece non ebbero dubbi su chi aveva armato la mano dell’assassino e colpirono certi di colpire giusto. Questo fatto è fondamentale.
Intanto il viceré aveva fatto allontanare dal regno l’avv.fiscale Antonio De Molina e il nipote del reggente Nigno, ritenuti complici dell’omicidio in quanto il marchese di Laconi fu trovato morto proprio di fronte alla casa del reggente. Si disse tosto che egli prese tale provvedimento perché costoro non rivelassero fatti per lui compromettenti.
Il giorno 21-7-1668, mentre il viceré in carrozza rientrava a casa con la famiglia dalla festa del Carmine cui era stato invitato dalla marchesa di Villasor, all’altezza di via dei Cavalieri (oggi via Canelles) dalla casa del mercante Antioco Brondo partirono delle schioppettate che lo freddarono dandogli appena il tempo di invocare la Madonna del Carmelo. I paggi ed i gentiluomini di scorta corsero a chiudere le porte della città; ma giunti presso la torre dell’Aquila da un balcone della adiacente casa del marchese di Villacidro (oggi casa Zapata) partirono altri 5 colpi di moschetto che ferirono un gentiluomo e un domestico del viceré. Altri colpi partirono dalla casa di Francesco Cao Junior.
Nella casa del Marchese di Villacidro si trovava Jacopo Artaldo di Castelvì, Marchese di Cea cugino dell’estinto, lo stesso Marchese don Antonio Brondo, don Francesco Cao, don Francesco Portogues, e pochi altri che per mettersi in salvo dalle ire dei familiari del viceré che volevano dar fuoco alla casa si rifugiarono nel convento di San Francesco di Stampace.
La morte del Viceré di ritenne in Spagna dovuta ad un movimento di ribellione contro la Corona, data anche la situazione sarda dipinta dal Camarassa a Madrid con foschi colori.
La Reale Udienza Viceregia Gubernante (in attesa che rientrasse da Sassari il Governatore di Cagliari Don Bernardino Mattia di Cervellon cui spettava, fino all’arrivo del nuovo viceré, la Presidenza del Regno), prese le precauzioni per mantenere l’ordine e proteggere la famiglia Camarassa. Nello stesso tempo chiese pronti soccorsi a Napoli e Sicilia. Il Principe di Piombino comandante delle galere sarde fece sbarcare alcune truppe. Offerta l’opera sua alla R.Udienza, ebbe il comando militare e la custodia del Castello fino al rientro del Cervellon, suscitando le proteste della nobiltà urtata da quel provvedimento.
Diversi feudatari (conte di Monteleone e d’Albis, conti di Montalvo e Villanova) accompagnati da numerosi popolani armati si portarono alla R.Udienza ed ottennero la revoca dell’ordine che suonava sfregio alla nazione sarda. In quel momento, se la nobiltà avesse voluto impadronirsi del governo e rovesciare il dominio di Spagna, vi sarebbe riuscita avendo dalla sua anche le milizie nazionali, prova ne sia che invitate si rifiutarono di fare la guardia al palazzo reale. Gli stessi militi affermavano che il Camarassa era stato ucciso per le reazioni da lui provocate come privato e che non si era voluto colpire in lui il rappresentante regio.
Intanto l’arcivescovo Pietro Vico, pur essendo partigiano del Marchese di Laconi, si era assunto il cavalleresco e pietoso incarico di far imbarcare la famiglia della viceregina e di equipaggiarla del necessario. Con lei si imbarcò anche il principe di Piombino così visto di mal’occhio dalla nobiltà sarda.
Intanto il 2-8-1668 don Bernardino di Cervellon assumeva la presidenza del Regno nonostante fosse cognato del marchese di Cea e stretto parente di Don Agostino di Castelvì nonché di altri suoi aderenti, cosa che costituiva per lui una grave incompatibilità.
Il primo processo imbastito sui due omicidi fu favorevole alla Zatrillas (la R.Udienza, per il modo con cui era composta, era legata da vincoli di amicizia e parentela coi Castelvì e con coloro che la voce pubblica additava come uccisori del viceré) poiché accolse come buone le sue accuse e le testimonianze da lei esibite, particolarmente importante tra esse, quella della guardarobiera della viceregina donna Isabella di Portocarrero, certa Cannas, la quale depose sull’intenzione manifestata da costei di far uccidere il viceré.
I giorni seguenti all’omicidio i familiari di casa Camarassa avrebbero ostentato allegria. Altri deposero sul contegno offensivo e sulle ingiurie rivolte dai familiari del viceré alla memoria del Marchese di Laconi. Altri ancora confermarono che la voce pubblica attribuiva alla Camarassa la preparazione, al De Molina Avv. Fiscale, al De Pedrassa Commissario General della Cavalleria, al Nigno nipote del reggente e al Clavaria altro funzionario l’esecuzione del delitto, tanto che il Molina e il Nigno erano stati dal viceré sottratti alla punizione. La marchesa di Camarassa si sarebbe vantata dell’assassinio del Castelvì minacciando della stessa sorta tutto quel casato. Altri ancora riferirono un colloquio in cui la marchesa di Camarassa avrebbe addirittura dato al Nigno ed al Molina il mandato di uccidere il marchese. In seguito a queste deposizioni furono arrestati don Antonio De Pedrassa, Don Francesco De Clavaria e certo Giuseppe Bono.
Il secondo processo, fatto istruire dal viceré Duca San Germano rovesciò completamente tutte le posizioni annullando il valore di tali testimonianze come estorte con le intimidazioni e le violenze. Superfluo dire che gli arrestati furono rimessi in libertà.
Notevole che in quel primo processo nessuna accusa fu accertata a carico dei condannati nel secondo e del Marchese di Cea che si giustificò nel modo che si è detto. Si accertò invece la colpevolezza di certo Antioco Dettori che introdusse nella casa Brondo i sicari del Viceré: ma costui fuggì in Gallura ove si narrò fosse stato ucciso da alcuni banditi. La sua testa fu pertanto messa a prezzo dal Governatore Cervellon. Ma la realtà di questo Dettori, anche se accertata, non risolveva affatto la questione dei mandanti dell’uccisione.
Intanto la Zatrillas, che si era rifugiata a Cagliari con don Silvestro Aymerich menando, si disse, vita spensierata (cosa che doveva suscitare commenti e critiche), annunciava allo zio Marchese di Cea nell’ottobre dello stesso anno il suo matrimonio con l’Aymerich dopo aver sdegnosamente respinto la domanda della sua mano inoltrata dal conte di Sedilo, cui lo zio sarebbe stato invece favorevole.
Il matrimonio affrettato di don Silvestro e donna Francesca Zatrillas diede esca al duca di San Germano di imbastire a loro carico l’imputazione dell’assassinio di don Agostino allo scopo di rendere possibile la loro unione, tesi che faceva comodo al fisco. Il matrimonio, secondo la versione data dal Marchese di Cea sarebbe stato anzi affrettato dalla marchesa di Villasor servendosi del gesuita padre Salaris allo scopo di fornire in tal modo una causa passionale all’uccisione del marchese di Laconi.
Intanto il Marchese di Cea, con don Agostino Brondo Marchese di Villacidro, don Francesco Cao, don Giacomo Portugues, don Gavino Grixoni erano passati ad Alghero accolti festosamente dal popolo, e ossequiati dai Consiglieri della Città e dal Capitolo. Così pure a Sassari e ad Ozieri. Che egli e i suoi amici non nutrissero alcun progetto autonomistico lo dimostrano i fatti stessi.
La partita era ormai perduta per la nobiltà sarda troppo debole per imporsi ai potentati spagnoli della corte e del Supremo Consiglio d’Aragona per cui erano sempre dei vassalli riottosi da ridurre a dovere. Donde l’invio del nuovo viceré Duca di San Germano Francesco Tutavilla, duro e intransigente fino alla ferocia, che il 26.12.1668 entrava in Cagliari col fratello don Vincenzo.
Con abito soldatesco e senza alcun tatto si accinse ad eseguire gli ordini di Madrid: punire i colpevoli, domare la ribellione e purgare da ogni accusa la marchesa di Camarassa rovesciando ogni responsabilità dell’accaduto sugli elementi locali. Creò così una frattura profonda tra il governo e la nobiltà sarda.
Questa, ingannata, disillusa su una possibile azione coercitiva si mise a disposizione del viceré. Lo stesso Marchese di Cea gli indirizzò una lettera augurale e di giustificazione professandosi disposto a ultimare i suoi giorni nel convento di Ozieri.
Nel 1669 furono annullati i precedenti atti processuali e diressero la nuova macchina giudiziaria il Consultore Herrera, l’Avv. Fiscale Stefano Alaman e il giudice della R. Udienza don Giorgio Cavassa. L’Herrera, perseguendo i desideri della corte, fece dare un bando in cui si concedeva un’amnistia generale (eccettuato il crimine di lesa maestà) a quanti, nel termine di due mesi, rientrassero nella legalità e riferissero le circostanze dei due omicidi, minacciando invece la morte e la confisca dei beni a coloro che continuassero ad aderire ai ribelli. Era il modo per polverizzare ogni resistenza e di procurarsi le prove necessarie per imbastire nel senso desiderato al secondo processo. Così, nell’aprile 1669 si iniziarono le nuove istruttorie previo annullamento delle precedenti.
Riesaminati i testi del primo processo fu ottenuta la ritrattazione delle prime deposizioni ed essi dichiararono, messi alle strette, di essere stati subornati dal dottor Saturnino Vidal che fu subito carcerato. Fra il servidorame si trovò tanto da dipingere la marchesa Zatrillas come presa da smanie erotiche per il prestante cugino. La cameriera Giovanna Vara dichiarò di aver avuto confidenze dalla sua padrona circa la parte avuta nell’omicidio di don Agostino dai due amanti e di aver contemplato insieme alla Zatrillas la scena sanguinosa dell’assassinio da un balcone di Casa Laconi.
I mezzi con cui i giudici potevano allora estorcere confessioni erano terribili. Ai reticenti, o supposti tali, provvedevano le gradazioni della tortura e, a parte questa, era sufficiente il terrore delle pene crudeli proprie dei sistemi del tempo per chi fosse colpito dell’accusa di complicità e di reticenza. Basti dire che il servo del marchese di Laconi Francesco Cappai fu arruotato vivo. Tale constatazione è sufficiente per gettare la massima diffidenza su quelle deposizioni ottenute non sappiamo con quali mezzi e procedimenti inquisitori.
Anche persone di conto fecero la loro parte. Don Antonio de Sena, famiglio del Marchese di Laconi, accennò alla corrispondenza amorosa a mezzo di gesti fra donna Francesca e don Silvestro e alle pressioni fattegli nel primo processo per deporre contro la marchesa di Camarassa, don Antonio Molina e gli altri ministri spagnoli. I più importanti testimoni del primo processo deposero tutti in senso contrario a quanto avevano dichiarato.
Ammettendo come vere queste deposizioni si dovrebbe concludere che fin da quando don Agostino era in vita la tresca della moglie con don Silvestro era di dominio pubblico e che doveva essere necessariamente di dominio pubblico il sospetto della loro complicità nell’omicidio. Possibile, torniamo a dire, che nessun sospetto su codesti possibili mandanti avesse sfiorato la mente di una cinquantina di gentiluomini e di una ventina fra religiosi e curiali che presero parte al complotto per l’uccisione del Camarassa e che essi tutti ritenessero come articolo di fede la colpevolezza del viceré meditandone la morte a vendetta del Castelvì?
Mentre proseguiva il processo, il viceré diffidava di tutto e di tutti tanto più che il Castelvì da Ozieri era in corrispondenza con i suoi aderenti di Cagliari tra cui sospettava l’arcivescovo Vico, il vescovo di Ales Brunengo, inclusi infatti poi nella lista dei colpevoli.
Nel frattempo però ricevette da Napoli 550 fanti tra spagnoli e napoletani e 12.000 scudi inviati dal viceré suo collega in quel regno. Poteva avere così le mani libere di agire e di usare la maniera forte. Arrestò pertanto e chiuse nella torre dell’Elefante il Governatore don Bernardino de Cervellon (10.6.1669); chiamò da Sassari don Gerolamo Zonza Capitano di Cavalleria di quel Capo e lo rinchiuse nella Torre di San Pancrazio. Don Francesco Cao senior (padre dello junior che era scappato con i congiurati) fu esiliato a Majorca e don Francesco Brunengo, uditore del R. Consiglio, messo a riposo. Il Vescovo di Ales Brunengo fu mandato a Toledo. Il dottor Saturnino Vidal, letterato e giurista, fu preso ed impiccato.
I due coniugi Aymerich, fiutato il vento, scapparono fuori dell’isola. Da Bosa raggiunsero Livorno ove il granduca non li volle accogliere, poi a Villafranca ed infine a Nizza. Il Marchese di Cea era sempre in Gallura protetto dalle popolazioni e dagli aderenti.
Ultimato il processo coi metodi che sappiamo, per bando del 23.5.1669 venivano citati don Giacomo Artaldo di Castelvì, don Antonio Brondo Marchese di Villacidro, don Francesco Cao Junior, don Francesco Portugues, don Silvestro Aymerich, don Gavino Grixoni e i fratelli Gluani a comparire davanti al viceré per rispondere delle accuse elevate dal fisco. Ugual bando fu dato il 7.6.1669 contro donna Francesca Zatrillas.
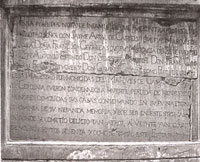 Spirati i termini, il 18.6.1669 fu pronunciata in contumacia la sentenza per cui come rei di alto tradimento e di lesa maestà in primo capite e come perturbatori della quiete pubblica erano condannati alla pena capitale ed alla confisca dei beni con facoltà a chiunque di ucciderli. Le case loro, compresa quella del mercante Antioco Brondo donde erano partite le schioppettate, venissero demolite (lo stesso Brondo fece il gesto teatrale di dare il primo colpo di piccone alla sua stessa casa come pubblica ostentazione della sua fedeltà al sovrano) passandovi l’aratro e il sale e vi fossero apposte lapidi con iscrizioni infamanti. Una di esse si legge ancora in Via Canelles nella ex casa Brondo, oggi Casa Asquer.
Spirati i termini, il 18.6.1669 fu pronunciata in contumacia la sentenza per cui come rei di alto tradimento e di lesa maestà in primo capite e come perturbatori della quiete pubblica erano condannati alla pena capitale ed alla confisca dei beni con facoltà a chiunque di ucciderli. Le case loro, compresa quella del mercante Antioco Brondo donde erano partite le schioppettate, venissero demolite (lo stesso Brondo fece il gesto teatrale di dare il primo colpo di piccone alla sua stessa casa come pubblica ostentazione della sua fedeltà al sovrano) passandovi l’aratro e il sale e vi fossero apposte lapidi con iscrizioni infamanti. Una di esse si legge ancora in Via Canelles nella ex casa Brondo, oggi Casa Asquer.
Con altro proclama pari data si proibiva ai sardi di aver alcun rapporto con costoro pena la vita, promettendo in pari tempo 6.000 scusi e il perdono di qualsiasi delitto per sé e altri dieci compagni a chi li avesse consegnati vivi alla giustizia e 3.000 scudi se fossero consegnati morti. Tutti gli abitanti di qualunque villa ove essi entrassero fossero tenuti ad ammazzarli. Finiva il proclama con una lisciatina di circostanza ai sardi che si erano mantenuti fedeli al sovrano in mezzo a tante turbolenze.
La lisciatina ebbe il suo effetto: i tre Stamenti ringraziarono il viceré, lasciando in pratica nella bagna i responsabili del movimento e riaccostandosi al viceré.
Con sentenza 6.7.1669 furono parimenti condannati a morte la Zatrillas e l’Aymerich e dichiarati innocenti la Camarassa e don Antonio Molina, don Giacomo di Clavaria, don Gaspare Nigno, don Antonio de Pedrassa e Giuseppe Bono. Tutta la cricca spagnola veniva pienamente riabilitata.
Dopo questa sentenza il Portugues, il Cao e il Grixoni si imbarcarono fuori Regno. Il Cao raggiunse i coniugi Aymerich a Nizza ove donna Francesca diede alla luce un figlio, Don Gabriele, che doveva poi essere reintegrato nel feudo di Sietefuentes. Il Marchese di Villacidro si ammalò e morì in Sardegna. Pure in Sardegna restò il Marchese di Cea godendo nel suo rifugio (il convento di Ozieri) dell’asilo. Tutti i feudi dei colpevoli ed i beni furono confiscati ed atterrate le case del Portugues in Cagliari e del Grixoni in Ozieri. La casa del Brondo (oggi Zapata col bel portale in marmo) contestata dalla figlia del Valdaura moglie di don Felice, come vedemmo restò in piedi e così le case della Zatrillas su cui gravavano varie ipoteche.
Il Cea, privo dell’aiuto dei compagni, si ritirò con alcuni fedeli sul Monte Nieddu (Gallura) dove il viceré cercò invano di catturarlo prima attraverso un numeroso esercito poi col solito mezzo sleale di promettere l’impunità a tutti i delinquenti del Monte Nieddu se avessero consegnato il Marchese; ma i banditi, più gentiluomini del viceré, sdegnarono di profittarsene. Il viceré aveva cercato anche di sbarazzarsi dei nobili che potevano ancora essere pericolosi, come il Conte di Monteleone, invitandolo ad unirsi alla spedizione con l’esercito ma il Conte di Monteleone, molto lealmente vista la parentela col Cea, rifiutò tale proposta.
La mentalità del viceré non era però capace di assurgere a tali finezze e diede altra interpretazione al rifiuto. Racconta l’Aleo che il Conte di Monteleone (Lussorio Roccamarti), il Conte di Sedilo (Gerolamo Cervellon), il Marchese d’Albis (Carlo Manca Guiso), il Conte di Villamar (Salvatore Aymerich) e quello di Montalvo (Felice Masones) furono arrestati nel palazzo reale dove si erano recati per fare gli auguri al viceré in occasione delle feste pasquali. Essi furono rinchiusi nella Torre dell’Elefante (la prigione di stato di allora) e poi trasportati in Spagna. Molto cavallerescamente il viceré, nell’informare la regina, proponeva che a los cuatro (Albis, Monteleone, Villamar e Montalvo) si dovesse cortar la cabeza oppure se S.M. volesse essere più benigna fossero tenuti perpetuamente in carcere in modo da non comunicare più con l’isola.
L’epilogo della tragica storia è noto. Il San Germano, di fronte alla fermezza dei Savoia che non vollero tradire l’ospitalità ai fuggiaschi, ricorse all’arma che maneggiava meglio di tutte, il tradimento. Egli trovò il suo uomo in don Giacomo Alivesi, colpevole di diversi omicidi che, fingendosi perseguitato dalla giustizia, si insinuò nell’animo poco accorto di don Francesco Cao che trovò a Roma e che gli servì da esca per trarre in trappola gli altri.
L’Alivesi gli propose un piano per indurre i sardi che egli diceva malcontenti del viceré ad una sollevazione generale. Avrebbe assoldato 300 banditi destinati ad aiutare lo sbarco dei fuoriusciti e fronteggiato in un secondo tempo le truppe regie. Il resto sarebbe venuto da sé.
Portatisi a Villafranca, il progetto piacque agli altri tranne che al Marchese di Cea il quale, recatosi ad accompagnarli ma deciso a non partire fu preso dai compagni a viva forza e gettato nella barca che li portò alla nave su cui dovevano raggiungere la Sardegna. Toccata la Corsica convennero di raggiungere Vignola nella Sardegna settentrionale. L’Alivesi avrebbe dato il buon esempio di sbarcare per primo. Nel frattempo si intese con don Gavino Delitala (soggetto degno di lui) il quale avrebbe radunato in Gallura quanti armati potesse. I due, con le vittime designate, passavano quindi da Vignola all’isola Rossa donde l’Alivesi si allontanò per tornare due giorni dopo con gli uomini armati i quali si mostrarono deferenti ed ossequiosi coi cinque fuggiaschi. Dopo lauta e cordiale cena, mentre le vittime si riposavano, furono aggredite (25.7.1671). Si difesero disperatamente il Cao, il Portugues e l’Aymerich di cui fu fatto scempio, mentre il marchese e il suo servo legati come salami furono condotti a Sassari.
Il delegato del viceré, dopo aver fatto cavare le cervella alle teste degli uccisi e averle fatte riempire di sale, diede un bando perché tutta la cavalleria, i titolati, i nobili, i cavalieri, i cittadini e la plebe, pena la vita e la confisca dei beni, si portassero a Cagliari ove in sinistro corteo dovevano essere condotti i condannati. Ad Alghero, puzzando le teste in modo che nessuno ardiva avvicinarsi al palco, esse furono trasferite a Porta Mare.
La marcia del corteo movente da Alghero durò 12 giorni. Il 9 giugno giunsero a Sant’Avendrace dove sostò per attendere gli ordini del viceré. Esso ordinò che l’ingresso in città avvenisse con grande spiegamento di forze e ne diede l’incarico al giudice Cavassa. La cavalleria precedeva il carnefice a cavallo con un tridente in cui erano infilzate le teste. Seguiva il vecchio Marchese avvilito e stanco, a piedi, con gli abiti logori e il servo Francesco Cappai che venne poi arruotato vivo. Il corteo percorse le principali strade della città a suon di tamburi e poi i due prigionieri furono chiusi nella torre dell’Elefante. Nel pomeriggio, perché la cerimonia fosse completa, una schiera di militi preceduti da tamburi e trombe seguiti dal boia, da ministri della cosiddetta giustizia e da sbirri, percorse le vie di Cagliari per mostrare le tre teste esposte poi su una tavola nel luogo ove fu consumato l’omicidio. Sotto la scorta di 50 soldati furono portate alla Torre dell’Elefante. Appese poi alla Torre di San Pancrazio furono di nuovo trasportate alla prima torre ove restarono 17 anni e furono rimosse solo il 1688 per grazia sovrana su petizione del parlamento.
Sei giorni dopo nell’attuale Piazza Carlo Alberto cadeva la testa di Jacopo Artaldo di Castelvì, valoroso militare e magistrato, con ogni probabilità innocente del delitto ascrittogli. Come nobile non poteva essere sottoposto a supplizio infamante per i privilegi dello Stamento militare. Il suo corpo, lasciato sul palco, fu sepolto dai nobili confratelli del Monte di Pietà e tumulato nella loro chiesa di Santa Maria del Monte (in via Corte d’Appello).
Il traditore Alivesi ebbe i ricchi feudi di Siligo e Banari confiscati al Marchese di Cea con la condizione di pagare 120 scudi annui al compare don Gavino Delitala di Nulvi detto “Bainzu Sgannau”. Di più, ebbe come premio 12 salvacondotti da vendere a banditi e galeotti.
Donna Francesca, la bella protagonista, finì in odore di santità in un monastero di Nizza. L’unico figlio nato da Don Silvestro Aymerich, don Gabriele, ottenne il reintegro del feudo di Sietefuentes e dei paterni, giacché, contrariamente alla tesi del San Germano, la maestà regia ritenne più tardi l’omicidio del Camarassa commesso per motivi privati e non in disprezzo della regia autorità. Gabriele sposò Donna Maria di Castelvì e per tale matrimonio i feudi di casa Laconi (marchesato di Laconi, contea di Villamar) passarono alla famiglia Aymerich dopo l’estinzione della linea maschile in don Francesco di Castelvì, lontano parente di Donna Maria di Castelvì. Nulla sappiamo della fine di Don Gavino Grixoni.
Resta in ultimo da dare un giudizio su questo complicatissimo quesito che, allo stato attuale dei documenti, è uno dei più difficili per lo storico.
Lo Scano, nel suo grandioso studio, rigetta sia la tesi antica condivisa dal Manno sia quella del Marchese di Laconi Don Ignazio Aymerich, Senatore del Regno. Egli non accoglie la prima tesi (quella ufficiale) in quanto non gli sembra attendibile che la tresca dei due amanti, vivente il marito, non fosse a conoscenza di tutta Cagliari, o almeno dei parenti. Non crede alla colpevolezza della Zatrillas e dell’Aymerich ritenendo estorte le deposizioni contro di loro o interessate per ottenere l’impunità. Furono il duca di San Germano e il consultore Herrera a connettere per primi l’omicidio del Castelvì col matrimonio dei due. Anche il pontefice concesse la regolarizzazione della loro unione, la nobiltà sarda continuò ad essere solidale con loro e così il venerando Marchese di Cea. I Savoia accolsero i due coniugi con onori e cortesie e, a posteriori, ne sanzionò l’innocenza la Reale Udienza che diede parere favorevole al reintegro dei feudi suindicati in persona di Gabriele Aymerich.
La Scano non accetta neanche la seconda versione che rigetta le colpe sui Camarassa. Le deposizioni dei testimoni del primo processo meritano per lui la stessa fede di quelle del secondo rese in senso opposto dalle medesime persone. Fanno ostacolo, egli dice, ad ammettere la colpevolezza dei Camarassa l’alta educazione della viceregina e della sua famiglia, le sue convinzioni religiose, il carattere mite del viceré, l’interesse a non sollevare la reazione dei sardi.
Egli prospetta un’altra ipotesi che avrebbe dovuto affacciarsi ai primi giudici incaricati dell’istruttoria e che fu scartata. Quella cioè che il Castelvì, impenitente donnaiolo, fosse stato vittima di una vendetta d’onore dovuta al congiunto di una sua amante (Il Castelvì per fatto di donne rischiò di essere colto da due schioppettate che gli furono tirate il venerdi santo del 1649).
Il Castelvì, aggiunge, si urtò con don Blasco Alagon proprio per ragioni di gelosia e poco mancò che i vassalli armati dei due non si azzuffassero malamente fra loro.
Lo Scano poggia quest’ipotesi su una notizia del Padre Aleo. Il Marchese, racconta l’Aleo, la sera dell’omicidio era uscito non per godersi il fresco, ma per trovarsi con una dama. Di più, nel processo, certo Pinna, riportiero di casa Laconi depose che egli teneva pratica carnale con donna Maddalena Cugia la quale avrebbe proposto al Pinna di avvelenare donna Francesca di cui era gelosa. Egli finse di accettare ma svelò la cosa alla Zatrillas e poi, per sfuggire alla vendetta giurata dalla Cugia, se ne scappò in Continente.
La versione vera resta pertanto per lo storico nel buio più assoluto. Resta però da considerare quanto fosse allora di moda il delitto politico e come si ritenesse giustificato dalla ragione di stato. Può escludersi che altrettanto non sia avvenuto in Sardegna per sciogliere alla Corte una situazione difficilissima?
Se non proprio il viceré, potrebbe essere stato il suo entourage ad effettuare quanto era ritenuto necessario per debellare l’opposizione. Ed allora ci troveremmo di fronte ad uno dei tanti delitti politici di cui abbonda la storia, giustificati dalla ragione di stato.
Il Castelvì aveva non pochi nemici nel partito governativo e la nobiltà ne considerò (a torto o a ragione) responsabile il viceré sicura che il colpo veniva da quella parte. Gli ostacoli che poi si affacciano allo Scano per ammettere la colpevolezza del Camarassa non sembrano insormontabili, né suscitano evidentemente nell’animo dei congiurati alcuna traccia di esitazione quando ne meditarono e perpetrarono la morte. Per essi il Camarassa era il vero colpevole e non ne dubitarono un istante.
Forse un giorno, frugando nei carteggi spagnoli di quel periodo, la verità potrà balzare fuori inattesa. Alla corte e al San Germano occorrevano dei capri espiatori come in genere nei processi politici e non certo essa avrebbe consolidato la sua posizione in Sardegna o riguadagnato il suo prestigio sanzionando in una pubblica sentenza l’azione omicida del suo governo contro il leader degli interessi sardi.
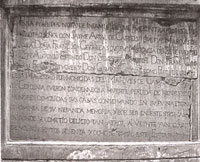 Spirati i termini, il 18.6.1669 fu pronunciata in contumacia la sentenza per cui come rei di alto tradimento e di lesa maestà in primo capite e come perturbatori della quiete pubblica erano condannati alla pena capitale ed alla confisca dei beni con facoltà a chiunque di ucciderli. Le case loro, compresa quella del mercante Antioco Brondo donde erano partite le schioppettate, venissero demolite (lo stesso Brondo fece il gesto teatrale di dare il primo colpo di piccone alla sua stessa casa come pubblica ostentazione della sua fedeltà al sovrano) passandovi l’aratro e il sale e vi fossero apposte lapidi con iscrizioni infamanti. Una di esse si legge ancora in Via Canelles nella ex casa Brondo, oggi Casa Asquer.
Spirati i termini, il 18.6.1669 fu pronunciata in contumacia la sentenza per cui come rei di alto tradimento e di lesa maestà in primo capite e come perturbatori della quiete pubblica erano condannati alla pena capitale ed alla confisca dei beni con facoltà a chiunque di ucciderli. Le case loro, compresa quella del mercante Antioco Brondo donde erano partite le schioppettate, venissero demolite (lo stesso Brondo fece il gesto teatrale di dare il primo colpo di piccone alla sua stessa casa come pubblica ostentazione della sua fedeltà al sovrano) passandovi l’aratro e il sale e vi fossero apposte lapidi con iscrizioni infamanti. Una di esse si legge ancora in Via Canelles nella ex casa Brondo, oggi Casa Asquer.